|
RELAZIONE
SULLA PRIMA E SECONDA CAMPAGNA DI SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO LA TOMBA DI
GIGANTI DI ISCRALLOTZE
Dal
1 luglio 2009 è in corso, e
si concluderà il 30 settembre prossimo, la seconda campagna di scavo
archeologico presso la tomba di giganti di Iscrallotze,
Aidomaggiore.
La
prima campagna che ha avuto luogo nei mesi di luglio e settembre 2008 è
stata condotta nell’ambito delle attività pratiche e di tirocinio degli
studenti universitari dei corsi universitari di Archeologia e Beni
Culturali dell’Università di Sassari.
I
lavori diretti dalla prof.ssa Anna Depalmas docente presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, congiuntamente al dott.
Alessandro Usai funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Sardegna, sono stati condotti sul campo insieme alla dott.ssa Silvia
Vidili, e hanno visto la partecipazione -non contemporanea ma organizzata
in turni di scavo- di circa venti studenti dell’Università di Sassari,
frequentanti i corsi di Laurea triennale e magistrale di Scienze dei Beni
Culturali e del curriculum in Archeologia Subacquea attivato nella sede gemmata di
Oristano.
 La
seconda campagna di scavi (luglio - settembre 2009)
ha visto l’attivazione da parte dell’Amministrazione di
Aidomaggiore di un cantiere comunale per il quale sono stati assunti
quattro operai e un’archeologa, la dott.ssa Silvia Vidili che, nel mese
di settembre, ha suddiviso il lavoro con la dott.ssa Giovanna Fundoni. La
seconda campagna di scavi (luglio - settembre 2009)
ha visto l’attivazione da parte dell’Amministrazione di
Aidomaggiore di un cantiere comunale per il quale sono stati assunti
quattro operai e un’archeologa, la dott.ssa Silvia Vidili che, nel mese
di settembre, ha suddiviso il lavoro con la dott.ssa Giovanna Fundoni.
Insieme
ai lavori di scavo si è proceduto alle operazioni di registrazione,
catalogazione, lavaggio e siglatura dei materiali archeologici ritrovati
e custoditi presso gli idonei locali messi a disposizione dal
Comune.
Alle
operazioni di scavo e alle attività di laboratorio hanno partecipato
studenti del corso di Laurea magistrale in Scienze dei Beni Culturali
dell’Università di Sassari, volontari dell’Università di Sassari,
laureati in Archeologia della terza Università
di Roma, una dottoranda presso l'Università di Parigi X
Nanterre e due archeologi preistorici, ricercatori presso il Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas in Portogallo. Gli studenti, i volontari e gli
studiosi partecipanti allo scavo hanno soggiornato nel paese di
Aidomaggiore presso un alloggio messo loro a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, potendo
così avere l’opportunità di entrare a contatto e di conoscere un
territorio di grande interesse per il numero e la varietà tipologica del
suo patrimonio archeologico.
Il
monumento
La
scelta di indirizzare l’azione di valorizzazione su questo monumento è
stata dettata da diversi fattori, quali il discreto stato di
conservazione, la facile accessibilità e l’interesse scientifico
determinato dalla presenza di alcuni particolari elementi architettonici
che caratterizzano il monumento.
Il
monumento è situato sull’orlo del pianoro ad una manciata di metri
dalla strada provinciale n. 66 che collega i paesi di Sedilo e Borore, ed
è raggiungibile da tale strada, percorrendo un tratto di circa due
chilometri dal bivio che conduce al paese di Aidomaggiore, verso la
direzione Sedilo,.
Nei
sopralluoghi precedenti l’inizio dei lavori si poté osservare a fatica
lo sviluppo del corridoio funerario e alcuni frammenti della stele immersi
in una fitta vegetazione mentre apparvero con evidenza le tracce di scavi
clandestini effettuati nella parte iniziale del corridoio.
Secondo
alcune notizie orali, il monumento si presentava intatto fino agli anni
settanta, in seguito avrebbe subito gravi danni, soprattutto alla
copertura e alla stele posta al centro dell’esedra, causati,
probabilmente, dall’esplosione di mine impiegate per la costruzione
della strada Sedilo – Borore che passa ad una decina di metri dal
monumento.
La
tomba, orientata a SE, è ubicata, in posizione dominante, sul margine del
pianoro, ad un’altitudine di m 314 s.l.m. con un orientamento
indirizzato verso la vallata, attualmente occupata dal Lago Omodeo.
Il
monumento è realizzato in tecnica a filari di grandi massi  non
sbozzati e, in origine, presentava al centro dello spazio semicircolare
frontale (esedra) una grande“stele centinata”, realizzata mediante due
lastre sovrapposte, la superiore con lunetta e l’inferiore con portello
d’ingresso. non
sbozzati e, in origine, presentava al centro dello spazio semicircolare
frontale (esedra) una grande“stele centinata”, realizzata mediante due
lastre sovrapposte, la superiore con lunetta e l’inferiore con portello
d’ingresso.
Già
nella fase di documentazione preliminare all’inizio dei lavori (e
coincidente con l’elaborazione del lavoro di tesi di laurea: Silvia
Vidili, Proposte per la
conservazione integrata e la valorizzazione del patrimonio monumentale del
comune di Aidomaggiore (OR), Università di Sassari A.A. 2003-04), si
notò che la lunghezza dall’abside alla corda dell’esedra era di circa
26,55 metri, dimensione che supera abbondantemente la lunghezza media
delle tombe di giganti (m 15,55) e che permette di inserire il monumento
tra quelli con le dimensioni maggiori (Su Monte ’e S’Ape, Olbia, m
28,30; Li Loghi, m 27,10; San Cosimo, Gonnosfanadiga, m 26,30; Goronna,
Paulilatino, m 24,60).
L’esedra
(freccia m 9,30, corda m 15,35 circa) è definita dai bracci laterali
dell’emiciclo di cui residuano, in modo a tratti discontinuo, i grandi
massi del filare di base: sei nella parte destra, dodici nell’ala
sinistra.
 La
camera sepolcrale, lunga m
7,30, appariva in parte ostruita dal terriccio e dai detriti dovuti al
crollo della parte sommitale della copertura; quest’ultima si presenta
ancora intatta nella parte finale della camera coperta da tre lastroni, il
primo dei quali frantumato in tre parti. La
camera sepolcrale, lunga m
7,30, appariva in parte ostruita dal terriccio e dai detriti dovuti al
crollo della parte sommitale della copertura; quest’ultima si presenta
ancora intatta nella parte finale della camera coperta da tre lastroni, il
primo dei quali frantumato in tre parti.
La
camera è a sezione ogivale e presenta, nella parete destra all’inizio
della camera una nicchia ricavata entro una lastra di grandi dimensioni.
Lo
spessore murario del monumento risulta particolarmente sviluppato (m 8,40)
fra la lastra terminale del corridoio e la parete esterna absidata, mentre
è di circa m 6,00 nella fiancata Nord-Est. La struttura muraria della
camera appare costituita da almeno quattro paramenti (esterno, interno e
due intermedi) le cui intercapedini sono riempite da pietrame e terriccio.
Della
stele centinata bilitica rimangono sei frammenti dello spartito inferiore
e tre della lunetta superiore, in cui si nota la presenza di tre cavità
realizzate nella parte sommitale, funzionali ad accogliere tre piccoli
elementi litici di forma conica (betilini),
uno dei quali rinvenuto nel corso dello scavo del 2009. Accostando i tre
frammenti della lunetta superiore si ottiene una larghezza di m 1,90 e
un’altezza residua di m 2,30.
Per
quanto riguarda lo spartito inferiore, invece, non è possibile stabilire
con esattezza la larghezza essendo andata persa tutta la parte centrale,
ma si ha la dimensione dell’altezza che è di m 2,00 circa.
La campagna 2008
La
prima fase dei lavori (4-14 luglio 2008) è stata dedicata alla pulizia
approfondita del monumento con il decespugliamento, il taglio di alcune
radici superficiali ed il diserbo. Contemporaneamente si è proceduto alla
quadrettatura dell’area, per unità di 1 x 1 metri, distinte attraverso
il posizionamento di picchetti, chiodi e punti colorati apposti con la
vernice in corrispondenza delle pietre della struttura o dei massi
rocciosi affioranti dal terreno.
Lo
scavo archeologico è iniziato con l’asportazione del terreno
superficiale 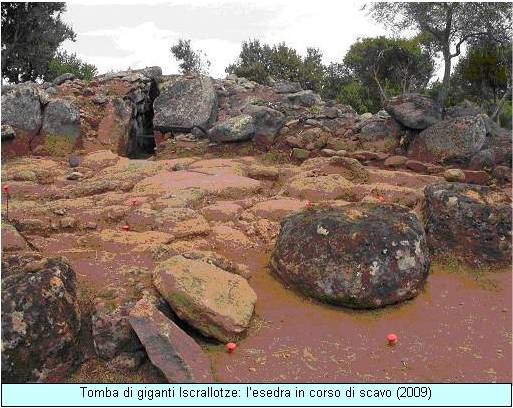 di
natura umifera, presente su tutta l’area. In particolare i lavori del
mese di luglio si sono concentrati in corrispondenza del lato orientale
esterno della camera (lato SO). La
fiancata Sud-Ovest non era infatti leggibile poiché coperta da uno spesso
strato di terra che si presenta al medesimo livello altimetrico della
sommità della copertura di
natura umifera, presente su tutta l’area. In particolare i lavori del
mese di luglio si sono concentrati in corrispondenza del lato orientale
esterno della camera (lato SO). La
fiancata Sud-Ovest non era infatti leggibile poiché coperta da uno spesso
strato di terra che si presenta al medesimo livello altimetrico della
sommità della copertura
In
questa zona l’asportazione
del deposito, corrispondente oltre che al terreno superficiale ad accumuli
non coerenti di pietre, ha permesso di
portare in luce le pietre pertinenti alla struttura muraria.
La
camera sepolcrale si presentava in parte ostruita da terriccio e detriti
dovuti al crollo della parte sommitale della copertura.
La campagna 2009
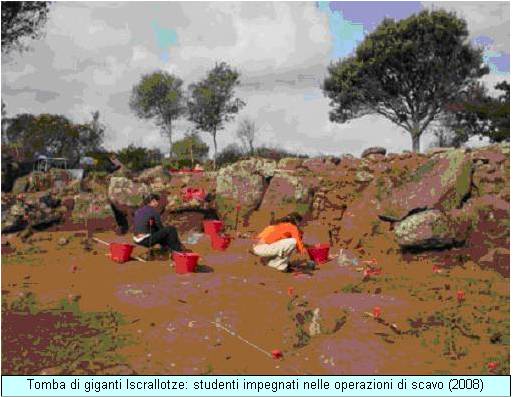 I
lavori –attualmente in corso- sono stati finalizzati all’ultimazione
delle fasi operative avviate nel corso della campagna precedente. I
lavori –attualmente in corso- sono stati finalizzati all’ultimazione
delle fasi operative avviate nel corso della campagna precedente.
Si
è quindi proceduto all’estensione della quadrettatura di tutta l’area
entro cui si sviluppa la struttura, con il posizionamento di chiodi,
picchetti e punti di riferimento sino alla composizione di un vasto
reticolo composto da quadrati di un metro per lato.
In
particolare, dopo il rilievo fotografico e grafico nonché la quotatura
strumentale, è stata effettuata la pulizia e la rimozione del pietrame
superficiale della zona absidale della tomba. Tali operazioni hanno
permesso di evidenziare la presenza di una sorta di basamento monumentale
che interessa il lato orientale più esterno della camera e, un breve
tratto dell’abside, sul quale è stato eretto il paramento della camera.
La
pulizia della struttura muraria di questa parte del monumento ha permesso,
infatti, di meglio evidenziare il dispositivo costruttivo adottato per
l’edificazione della tomba, con paramenti paralleli che, attualmente, a
causa dei parziali crolli, si presentano
con un aspetto a gradoni.
Il
completamento dello scavo nella zona antistante il fronte della tomba
(esedra) ha permesso di verificare l’estensione del banco roccioso
naturale sul quale l’edificio risulta direttamente impostato. Oggi il
naturale degrado del basalto –che in corrispondenza del banco risulta
particolarmente bolloso e fragile - conferisce al piano di base un aspetto
molto irregolare con fessurazioni e dislivelli e solo in alcuni tratti
appare evidente l’intervento dell’uomo che in antico vi ha operato
tagli artificiali e livellamenti.
La
zona a ridosso del braccio orientale dell’esedra, ai piedi del basso
bancone evidenziato nel corso della precedente campagna, ha restituito il
maggiore quantitativo di materiale ceramico, e ha fatto ipotizzare che nei
tempi d’uso della tomba, questa parte dell’esedra fosse quella
riservata alla deposizione dei vasi e quindi delle offerte donate
nell’ambito dei riti in onore dei defunti.
L’analisi
preliminare di tali manufatti ha confermato l‘attribuzione cronologica
ad una fase iniziale del Bronzo medio, corrispondente alla facies
archeologica detta di “Sa Turricola”, confermata oltre che dal gran
numero di tegami, anche dal ritrovamento di anse ad appendici cornute e
prese forate.
Tale
attribuzione culturale riveste un particolare interesse perché per
la prima volta essa può essere associata ad un tipo di tomba di
giganti che presenta uno sviluppo evolutivo rispetto alle tombe a
struttura ortostatico-dolmenico e stele centinata note nell’ambito di
questa facies culturale.
La
tomba di giganti di Iscrallotze fu, infatti, realizzata in una tecnica
mista 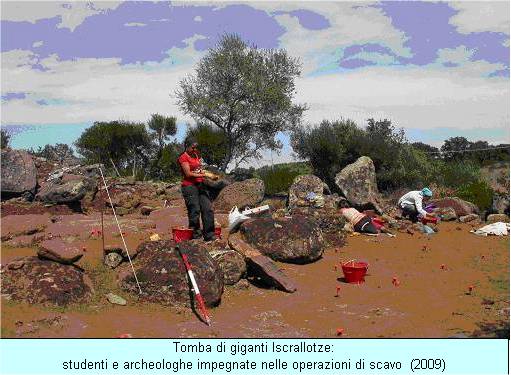 ad
ortostati e filari, con copertura interna della camera a filari aggettanti
e stele centinata con incavi, tutti indizi di una certa evoluzione
tecnica-costruttiva rispetto ai più antichi edifici funerari nuragici. ad
ortostati e filari, con copertura interna della camera a filari aggettanti
e stele centinata con incavi, tutti indizi di una certa evoluzione
tecnica-costruttiva rispetto ai più antichi edifici funerari nuragici.
Oltre
al completamento dello scavo per l’anno in corso è previsto il
rilievo grafico della tomba III di Sa Tanca ‘e S’Ozzastru che, insieme
ad altri due edifici analoghi (Tombe
I e II) si trova a circa 150
m dalla strada provinciale Sedilo
–Borore, a breve distanza dal monumento di Iscrallotze.
La
tomba di giganti III, analogamente alle altre due, si presenta in pessimo stato di conservazione; mostra l’esedra
orientata a sud est e parzialmente distrutta e il vano funerario quasi
sommerso dalle macerie.
Il
corpo centrale, lungo m 9,50 e largo m 5,20, si restringe verso la parete
posteriore che si chiude con l’abside. Il paramento esterno è
costituito da filari di pietre di medio spessore, ben sbozzate nella
faccia a vista, disposti lievemente in ritiro.
Il
vano funerario, di pianta rettangolare, è delimitato da una rozza
muratura a secco, con ortostati alla base sui quali poggiano due filari
residui di pietre appena sbozzate.
Al
centro doveva spiccare l'alta stele bilitica, lavorata con accuratezza
e decorata da una piatta cornice marginale; lo spartito inferiore
di essa, ancora in situ,
presenta inferiormente il portello funerario
e, superiormente la larga risega sulla quale si incastrava la parte
centinata, alta m 2, 40.
I
due monoliti della stele, sovrapposti, raggiungono l'altezza di m 3, 20.
Dell'esedra
si conservano tre lastroni di base dell'ala sinistra e la prima pietra del
secondo filare, il lato opposto è ricoperto di rovine. |